IL PUNTO DI SVOLTA......FRITJOF CAPRA

Il punto di svolta è il secondo saggio pubblicato da Fritjof Capra. Scritto durante la crisi economica e sociale dei primi anni 1980, il libro vuole tracciare un parallelo tra la crisi della fisica nei primi anni del XX secolo, e l'incapacità delle società contemporanee di far fronte a problemi di portata sistemica e globale come quelli economici ed ecologici. In questo senso, Il punto di svolta prosegue l'analisi iniziata dal precedente Il Tao della fisica.
Nell'analisi vengono esaminate le fondamenta della cultura occidentale, basate sul meccanicismo e sulla visione cartesiana, derivate dalle teorie di Locke, Descartes e Bacone, le quali portano alla stessa fisica classica.
La tesi del libro è che, come la fisica ha dovuto abbandonare la visione riduzionista per indagare l'infinitamente piccolo e l'infinitamente grande (teoria dei quanti e relatività), lo stesso dovrebbero fare medicina, biologia, sociologia ed economia. Nel libro è presente una chiara denuncia alle posizioni dello stile di vita occidentale, che non rispettano né le persone né le convenzioni sociali, ma incentrano il loro interesse egoisticamente sul singolo, sia come produttore, sia come consumatore. La critica di Capra non si rivolge esclusivamente al capitalismo, ma anche al marxismo ed al socialismo.
Pur datato, il libro anticipa in effetti alcuni mutamenti di paradigma, nel senso di Kuhn, poi effettivamente verificatisi: nelle scienze cognitive, con la visione diunità mente-corpo; nelle scienze biologiche, con il crollo dell'assioma genetico che asserisce "un gene, una proteina"; nelle scienze sociali ed economiche, con l'incapacità di prevedere crisi e tracolli, come la bolla del 2001 o la crisi petrolifera iniziata nel 2005, con il greggio che sale oltre i 70 dollari al barile per rimanervi, quando solo nel 2003 si parlava ancora del prezzo troppo basso del petrolio.
Anche se a volte Capra parteggia per la visione sistemica e olistica, tuttavia afferma immediatamente che il suo scopo non è ribaltare le idee comuni, ma integrare le conoscenze derivate dal riduzionismo con quelle derivanti dalle relazioni tra le varie parti.

Fritjof Capra (Vienna, 1º febbraio 1939) è un fisico e saggista austriaco. Fisico e teorico dei sistemi è saggista di fama internazionale. Diventato famoso con Il Tao della fisica, del 1975, tradotto in italiano nel 1982 (Adelphi) ha visto la sua fama aumentare con la ristampa del 1989. Si è occupato anche di sviluppo sostenibile,ecologia e teoria della complessità. Così egli ha descritto la sua intuizione della realtà spirituale:
| « Cinque anni fa ebbi una magnifica esperienza che mi avviò sulla strada che doveva condurmi a scrivere questo libro. In un pomeriggio di fine estate, seduto in riva all’oceano, osservavo il moto delle onde e sentivo il ritmo del mio respiro, quando all’improvviso ebbi la consapevolezza che tutto intorno a me prendeva parte a una gigantesca danza cosmica. […] Sedendo su quella spiaggia, le mie esperienze precedenti presero vita; «vidi» scendere dallo spazio esterno cascate di energia, nelle quali si creavano e si distruggevano particelle con ritmi pulsanti; «vidi» gli atomi degli elementi e quelli del mio corpo partecipare a quella danza cosmica di energia; percepii il suo ritmo e ne «sentii» la musica: e in quel momento seppi che questa era la danza di Śiva, il Dio dei Danzatori adorato dagli Indù. » |
| (Il Tao della fisica, Adelphi, 1993, pp. 11-12) Fonte:.wikipedia.orgFritjof_Capra 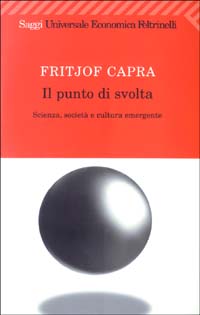
Fritjof
Capra : il punto di svolta
http://www.fritjofcapra.net/Sintesi dei capitoli più salienti dell'illuminante saggio di Fritjof Capra "il punto di svolta", che asserisce la necessità di una connessione tra tutti i campi delle scienze
Capitolo 1.
All’inizio degli ultimi due decenni del nostro secolo ci
troviamo in uno stato di crisi profonda a livello mondiale. È una crisi
intellettuale, morale e spirituale. Sintomi della crisi, indicatori di trasformazione
culturale.
1) abbiamo
accumulato ordigni nucleari e armi a discapito dei servizi sanitari. Le armi
nucleari non aumentano la nostra sicurezza ma solo la probabilità di una
distruzione globale;
2) Inquinamento
che comporta disastro ecologico: inquinamento dell’aria, dell’acqua e del cibo
che mangiamo, non colpisce solo gli essere umani ma sconvolge anche sistemi
ecologici : intossicazione chimica è diventato un rischio costante della nostra
vita;
3) Disgregazione
sociale; crimini, incidenti, alcolismo, abuso di farmaci, aumento di bambini
con difficoltà di apprendimento e disturbi del comportamento;
4) Al
deterioramento del nostro ambiente si accompagna un aumento dei problemi
sanitari degli individui: malattie croniche e degenerative definite malattie
croniche della civiltà, malattie cardiache, cancro, depressione, schizofrenia;
5) Anomalie
economiche: inflazione, disoccupazione, distribuzione ingiusta della ricchezza.
La dinamica che sottende tutti
questi problemi è la stessa: sono problemi sistemici, ossia interconnessi e
interdipendenti. La nostra è una crisi culturale o impasse concettuale che
potrà essere risolta solo modificando la struttura della rete stessa.
Questi problemi sistemici non
possono essere risolti singolarmente: bisogna adottare un angolo visuale il più
possibile ampio e operare verso la trasformazione.
L’idea di un ritmo universale
fondamentale è stata espressa da numerosi filosofi moderni, come ad esempio
Toynbee.
Secondo Toynbee la genesi di una civiltà consiste in una transizione da una
condizione statica a una condizione dinamica: il modello principale nella
genesi di una civiltà è visto come un modello di interazione che egli chiama
“sfida-e-risposta”: una sfida da parte dell’ambiente naturale o sociale provoca
in una società una risposta creativa che induce la società a entrare nel
processo di incivilimento. La civiltà continua a crescere fino a superare
l’equilibrio e a raggiungere uno squilibrio per eccesso che si presenta come
una nuova sfida. Il modello iniziale si ripete in fasi di crescita successive.
Tre transizioni dal vecchio al
nuovo paradigma:
-
declino del patriarcato;
-
declino dell’età dei combustibili fossili;
-
mutamento del paradigma vecchio: fede nel metodo
scientifico come unico approccio valido alla conoscenza, visione dell’universo
come sistema meccanico composto da parti elementari e materiali, la visione
della vita nella società come lotta competitiva per l’esistenza e la fede in un
progresso materiale illimitato da conseguirsi attraverso una crescita economica
e tecnologica.
La crisi presente non è una crisi di individui, di governi o
di istituzioni sociali, ma è una transizione di dimensioni planetarie. Come
individui, come società, come civiltà e come ecosistema planetario stiamo
raggiungendo il punto di svolta.
L’alternativa a questa concezione è quella marxista del
materialismo dialettico o storico, e del darwinismo sociale che pone troppo
l’accento sul conflitto e sulla lotta per la sopravvivenza dei più adatti, che
per Capra non sono indispensabili, dato che la transizione e la rinascita
culturale posso essere armoniose e pacifiche.
Capra si serve dello schema di riferimento dell’ I Ching, che è alla base del pensiero
cinese, che implica la nozione dei due poli archetipi, yin e yang, che
sarebbero alla base del ritmo fondamentale dell’universo. I filosofi cinesi
videro nella realtà, la cui essenza ultima chiamarono Tao (via) un processo di
flusso e mutamento continuo. L’aspetto essenziale dell’universo è il mutamento,
che è una tendenza naturale innata in tutte le cose; l’universo è impegnato in
un moto e in una attività incessanti, in un processo cosmico: Tao, la via. Tutte
le manifestazione del Tao sono generate dall’interazione dinamica dei due poli
archetipi. L’ordine naturale è un ordine di equilibrio dinamico tra yin e yang.
Quel che è buon non è yin o yang, ma l’equilibrio dinamico fra i due; quel che
è cattivo o dannoso lo squilibrio. Lo yin fu associato al femminile, lo yang al
maschile: la personalità di ciascun individuo, maschio o femmina non è
un’entità statica ma un fenomeno dinamico risultante dall’interazione di
elementi maschili e femminili. Questa concezione è in contrasto con quella
della nostra cultura patriarcale, la quale ha stabilito un ordine rigido nel
quale tutti gli uomini dovrebbero essere maschili, e tutte le donne femminili:
ha deformato il significato di tali termini assegnando agli uomini ruoli
dominanti e i privilegi sociali.
Yin: femminile, intuitivo, sintetico,attività ecologica,integrativo,cooperativo,
conservativo;
Yang: maschile, razionale, analitico,attività egocentrica,
autoassertivo, competitivo, dissipativo.
La nostra società ha favorito lo yang a scapito dello yin,
la conoscenza razionale a scapito di quella intuitiva, la scienza rispetto alla
religione, la competizione rispetto alla cooperazione: questo orientamento è
sostenuto dal sistema patriarcale e ha condotto ad uno squilibrio che è alle
radici della crisi corrente. Lo sfruttamento della natura è andato di pari
passo con lo sfruttamento delle donne: dai tempi più antichi la natura era
considerata come una madre generosa e nutrice o come una femmina selvaggia e
incontrollabile. Sotto il patriarcato l’immagine della madre benevola mutò in
passività e l’immagine della donna selvaggia diede origine all’idea che dovesse
essere dominata. Le donne furono ritratte come passive e subordinate : affinità tra femminismo e ecologia.
La consapevolezza ecologica solo quando combineremo la
nostra conoscenza razionale con un’intuizione del carattere non lineare del
nostro ambiente. Il nostro progresso fino a questo momento è stato
un’evoluzione unilaterale, ma dobbiamo spostare l’asse verso l’interrelazione e
l’interdipendenza di tutti i fenomeni, verso la teoria dei sistemi secondo cui
organismi viventi, società ed ecosistemi sono sistemi. I sistemi sono a multilivelli,
ciascuno è costituito da sottosistemi: molecole, organelli, cellule, tessuti,
organi, apparati, uomini e donne, famiglie, tribù, società, nazioni. Questi sub
sistemi che sono sia totalità sia parti sono detti oloni: ciascun olone ha due
tendenze opposte: una tendenza integrativa funzionare come parte di un tutto
maggiore (yin) e una tendenza auto assertiva a preservare la propria autonomia
intellettuale (yang). In un sistema sano c’è equilibrio dinamico fra
interazione e auto asserzione.
Stiamo assistendo ora d un’inversione della marea, della
fluttuazione tra yin e yang, allo sviluppo di una controcultura o cultura
nascente: punto di svolta.
Dalle teorie di Newton, Cartesio e Bacone, si pensava che la
macchina cosmica fosse composta di parti elementari; si credeva perciò di poter
sempre comprendere i fenomeni complessi riducendoli ai loro componenti
elementari e ricercando i meccanismi mediante i quali interagivano:
riduzionismo, spesso identificato con il metodo scientifico. Le concezioni
meccanicistiche e riduzionisti che della fisica classica sono accettate come la
descrizione corretta della realtà. Capra assegna alla fisica un ruolo
importante nella trasformazione della società: la fisica moderna può dimostrare
alle altre scienze che il pensiero scientifico non deve essere necessariamente
riduzioni stico e meccanicistico e che anche concezioni olistiche (mondo come
tutto indivisibile e armonico) ed ecologico sono scientificamente corrette. In fisica il paradigma meccanicistico dovette
essere abbandonato al livello del molto piccolo (fisica atomica e subatomica) e
del molto grande (astrofisica e cosmologia).
Le scienza naturali, anche le scienza umane e sociali devono
fare come la fisica: trascendere i modelli classici, andar oltre l’approccio
meccanicistico e riduzioni stico e sviluppare concezioni olistiche ed
ecologiche.
La scienza moderna è pervenuta a rendersi conto che tutte le
teorie scientifiche sono solo approssimazioni alla vera natura della realtà e
che ogni teoria è valida solo per un certo ambito di fenomeni.
Capitolo 4.
In biologia la visione dominante è quella cartesiana che
considera gli organismi viventi come macchine costruite con parti separate e
secondo la quale tutti gli aspetti degli organismi viventi possono essere
compresi riducendoli ai loro componenti minimi e studiando i meccanismi
mediante i quali tali componenti interagiscono tra di loro.
Secondo Dubos i biologi si trovano a loro agio soprattutto
quando la cosa che stanno studiando non è più viva. I problemi che i biologi
non sono in grado di risolvere oggi, in conseguenza della frammentazione del
loro approccio sembrano essere tutti connessi alla funzione dei sistemi viventi
come totalità e alle loro interazioni con il loro ambiente. Quando gli scienziati riducono un tutto
integrale ad una serie di componenti fondamentali – cellule, geni, o particelle
elementari- e tentano di spiegare tutti i fenomeni in funzioni di questi
elementi, perdono la capacità di comprendere le attività che coordinano l’intero
sistema. Ad esempio, i biologi conoscono l’alfabeto del codice genetico, ma non
hanno quasi nessuna idea della sua sintassi. Nella neurobiologia il sistema
nervoso è il sistema olistico per eccellenza le cui attività integrative non
possono essere intese riducendole a meccanismi molecolari. Per risolvere questi
problemi occorre un nuovo paradigma che trascenda la visione cartesiana.
Capitolo 5.
La biologia è sempre andata di pari passo con la medicina e
quindi la visione meccanicistica della vita ha influenzato anche la medicina.
L’influenza del paradigma cartesiano sul pensiero medico produsse il cosiddetto
modello biomedico che costituisce la
fondazione concettuale della moderna medicina scientifica, secondo la quale il
corpo umano è una macchina che può essere analizzata scomponendola nelle sue
parti; la malattia è vista come il cattivo funzionamento dei meccanismi
biologici che vengono studiati dal punto di vista della biologia cellulare e
molecolare. Il ruolo del medico consiste nell’intervenire per correggere il
cattivo funzionamento di un meccanismo specifico (corpo = macchina; malattia =
guasto della macchina, medico = colui che deve riparare la macchina). Una
persona sana è come un orologio ben costruito in condizioni meccaniche
perfette, una persona malata come un orologio le cui parti non funzionano nel
modo appropriato. La malattia deve essere invece considerata un disturbo
dell’intera persona, che coinvolge non solo il corpo del paziente, ma anche la
mente. Concentrandosi su frammenti del corpo sempre più piccoli la medicina
moderna perde spesso di vista il paziente come essere umano e riducendo la
salute ad un funzionamento meccanico non è più in grado di occuparsi del
fenomeno della guarigione. La ragione per cui la scienza biomedica ignora il
fenomeno della guarigione è che esso non può essere compreso in termini
riduzionistici, perché esso implica l’interazione complessa tra aspetti fisico,
psicologico, sociale e ambientale della condizione umana.
Il concetto ampio (olistico) di salute di cui avremo bisogno
per la nostra trasformazione culturale è che la salute è uno stato di completo
benessere fisico, mentale e sociale e non semplicemente l’assenza di malattia o
di infermità. Questo concetto olistico è esistito fino a che la filosofia di Cartesio
ha operato una divisione tra anima e corpo e ha condotto i medici a
concentrarsi alla macchina del corpo trascurando aspetti psicologici,
ambientali e sociali della malattia: si è sviluppato così lo scientismo medico,
che non riconosce l’arte di guarire della medicina popolare.
Benché la medicina abbia contribuito all’eliminazione di
certe malattie non ha però necessariamente restituito la salute: nella
concezione olistica dell’infermità, la malattia fisica è solo una di varie
manifestazioni di uno squilibrio di base dell’organismo.
La guarigione è esclusa dalla scienza medica poiché i
ricercatori si limitano ad uno schema che non consente loro di occuparsi in
modo significativo dell’interazione corpo, mente, ambiente. Per la guarigione è
rilevante anche lo stato psicologico e la tranquillità mentale e la fiducia
nella guarigione del paziente.
La spaccatura cartesiana tra mente e corpo ha portato ad una
separazione tra psicologia e medicina che ha rallentato l’individuazione di
molte malattie, ad esempio di quelle connesse allo stress.
Il sintomo è il tentativo dell’organismo di guarirsi: il
modello biomedico interferisce con questo processo di guarigione spontanea
sopprimendo i sintomi. La vera terapia consisterebbe nell’intensificare
l’attenzione al sintomo per completare il processo di guarigione. La terapia
medica corrente si fonda invece sul principio dell’intervento medico, cioè sul
fare affidamento su forza esterne per la guarigione senza prendere in
considerazione il potenziale di auto guarigione del paziente.
Il modello biomedico tende a escludere problemi filosofici
ed esistenziali come la morte, la malattia è vista come un nemico che deve
essere vinto, si riduce ad un guasto meccanico e la terapia a una manipolazione
tecnica: approccio ingegneristico alla salute; fa un uso ingiustificato della
tecnologia avanzata in medicina che deumanizza la pratica medica; considera la
malattia come la conseguenza di un attacco dall’esterno anziché un cedimento
all’interno dell’organismo.
Capitolo 6.
Gli psicologi,
seguendo Cartesio adottarono la rigorosa divisione tra res cogitans e res
extensa, che rese loro estremamente difficile capire in che modo mente e corpo
interagiscono. Le tre correnti principali del pensiero psicologico dei primi
decenni del XX secolo (strutturalisti,
behavioristi e la psicoanalisi) erano fondate non solo sul paradigma cartesiano
ma anche su concetti newtoniani.
Secondo Cartesio anima e corpo apparterrebbero a due regni
paralleli ma fondamentalmente diversi, ciascuno dei quali potrebbe essere
studiato senza alcun riferimento all’altro. Le teorie riduzionisti che e
materialistiche dei fenomeni psicologici suscitarono una forte opposizione in
psicologi che avevano una visione unitaria della natura della coscienza e della
percezione così si svilupparono secondo l’approccio olistico la psicologia
della Gestalt e il funzionalismo. La psicologia della gestalt si fondava
sull’assunto che gli organismi viventi non percepiscono le cose come elementi
isolati ma sulla base di gestante ossia di forme, di totalità significative che
presentano qualità assenti nelle loro singole parti. Il funzionalismo stabilì
un’importante connessione tra struttura e funzione e considera la coscienza un
fenomeno dinamico, ne investiga i modi di funzionamento specialmente in
relazione alla vita dell’intero organismo. Il principale esponente del
funzionalismo fu James, che criticava le tendenze atomistiche e meccanicistiche
in psicologia e fu un fautore entusiasta dell’interazione e
dell’interdipendenza di mente e corpo.
Durante i primi decenni del secolo il pensiero psicologico
fu dominato da due grandi scuole: il behaviorismo e la psicoanalisi che
differivano tra loro nei metodi e nella concezione della coscienza, aderendo
però allo stesso modello newtoniano di realtà:
Il behaviorismo
rappresenta il culmine dell’approccio meccanicistico in psicologia, si fonda su
una conoscenza minuziosa della fisiologia umana; i fenomeni manetali sono
ridotti a modelli di comportamento e il comportamento a precessi fisiologici
governati da leggi della fisica e della chimica- psicologia senz’anima. Il
fondatore fu Watson. La sua ambizione fu quella di innalzare lo status della
psicologia a scienza naturale obiettiva e a tale scopo egli aderì il più
fedelmente possibile alla metodologia e ai principi della meccanica newtoniana,
esempio eminente di rigore e obiettività scientifici. L’intero concetto di
coscienza quale risultava dall’introspezione doveva essere escluso dalla
psicologia, e tutti i termini affini come mente, pensiero e sentimento dovevano
essere eliminati dalla terminologia psicologica. Nella concezione
behavioristica gli organismi viventi erano macchine complesse che reagivano a
stimoli esterni e questo meccanismo stimolo-risposta era esemplato sulla fisica
newtoniana.
La psicoanalisi fu
fondata da Freud a partire non dalla psicologia ma dalla psichiatria. Freud fu
molto impressionato dagli studi di Charcot sull’ipnosi come trattamento
dell’isteria. Egli, con Breuer, sperimentò il metodo della libera associazione,
che consisteva nel porre i pazienti in uno stato di assopimento simile al sonno
e nel farli parlare liberamente dei loro problemi con speciale accento alle
esperienza emotive traumatiche. Freud scoprì l’inconscio, e vide in esso la
fonte essenziale del comportamento, mentre i behavioristi si rifiutarono di
riconoscerne l’esistenza. sottolineò che la nostra consapevolezza cosciente è
solo uno strato sottile che poggia su un vesto regno inconscio, governato da
forza pulsionali; sottolineò l’importanza delle esperienze infantili per lo
sviluppo dell’individuo e identificò nella libido o pulsione sessuale una delle
forza psicologiche principali e introdusse la nozione della sessualità
infantile. Un’altra scoperta fu l’interpretazione dei sogni,che definì la via
regia all’inconscio. Formulò una nuova teoria della personalità fondata su tre
strutture distinte dell’apparato psichico: es, io e super-io; scoprì il
transfert, cioè la tendenza dei pazienti a trasferire nell’analista una serie
di sentimenti tipici dei loro rapporti infantili con figure rilevanti della
loro infanzia, in particolare con i genitori.
Il rapporta tra psicoanalisi e fisica classica è
caratterizzato da 4 punti che sono la base della meccanica newtoniana:
1) il
concetto di spazio e tempo assoluti; punto di vista topico
2) il
concetto di forze fondamentali; pdv dinamico
3) il
concetto di leggi fondamentali;pdv economico
4) il
concetto di un determinismo rigoroso. pdv genetico
Come Newton fondò lo spazio euclideo assoluto come sistema
in cui gli oggetti materiali sono situati, così Freud fondò lo spazio
psicologico come sistema di riferimento per le strutture dell’apparato mentale
(es, io, super-io). Nella descrizione topica
di Freud l’inconscio contiene materiali che sono stati dimenticati o rimossi.
Nelle sue parti più profonde si trova l’Es, un’antietà che è la fonte di
profonde pulsioni, in conflitto con un sistema ben sviluppato di meccanismi
inibenti che hanno sede nel Super-io. L’Io è un’entità fragile situata in
posizione intermedia tra questi due poteri, ed è impegnato in una lotta
continua per l’esistenza.
L’aspetto dinamico
della psicoanalisi, come quello della fisica newtoniana consiste nel descrivere
in che modo gli oggetti materiali interagiscono tra di loro: le forze attive
sono dette pulsioni, le forze reattive sono dette difese. Altre coppie di forze
: libido e destrudo, eros e thanatos, una orientata verso la vita l’altra verso
la morte, che come nella dinamica newtoniana si presentano sempre in coppie di
direzione opposta.
[ la teoria dell’origine della nevrosi fu formulata in base al modello idraulico: le cause
primarie dell’isteria furono identificate come situazioni traumatiche
nell’infanzia del paziente che generano un’energia che se trattenuta o frenata
continua a cercare uno sfogo finchè non trova un’espressione attraverso vari
“canali” nevrotici. La terapia consiste nel richiamare alla memoria il trauma
in condizioni ch e consento uno scarica dell’energia rimasta senza sfogo. Poi
Freud abbandonò il modello idraulico perché i sintomi dei pazienti non derivano
da processi patologici isolati ma sono conseguenze del mosaico complessivo di
tutta la loro vita. Secondo questa nuova concezione, le radici della nervosi si
trovano in tendenze pulsionali prevalentemente sessuali che erano inaccettabili
e venivano rimosse da forze psichiche che le convertivano in sintomi nevrotici.
]
Freud attribuì grande importanza all’aspetto quantitativo o
“economico” della psicoanalisi.
L’approccio genetico
della psicoanalisi consiste nel ricondurre i sintomi e il comportamento del
paziente a fasi di sviluppo anteriori lungo una catena lineare di rapporti di
causa-effetto.
La divisione cartesiana di mente e materia si riflette nella
pratica psicoanalitica nella concentrazione esclusiva sui processi mentali: la
psicoterapia trascura il corpo come la terapia medica trascura la mante. Come
il modello newtoniano anche il modello freudiano è estremamente utile per
occuparsi di alcuni aspetti, ma è limitante se applicato alla totalità della
realtà fisica o mentale.
Capitolo 9.
La visione sistemica della vita è una nuova visione della
realtà che si fonda sulla interrelazione e interdipendenza di tutti i fenomeni,
fisici, biologici, psicologici, sociali e culturali. Considera il mondo in
termini di rapporti e di integrazioni; i
sistemi sono totalità integrate e dinamiche le cui proprietà non possono
essere ridotte a quelle di unità minori.
La descrizione riduzionistica può essere utile e in alcuni
casi necessaria: è però pericolosa quando viene assunta come una spiegazione
completa: riduzionismo e olismo sono approcci complementari.
Differenze essenziali tra un organismo e una macchina:
1) le
macchine vengono costruite, gli organismi crescono;
2) le
macchine sono montante in modo preciso e prestabilito, gli organismi rivelano
un alto grado di flessibilità e plasticità interne;
3) le
macchine funzionano secondo catene lineari di causa-effetto, il funzionamento
degli organismi è guidato da modelli ciclici di flusso di informazione;
4) Le
macchine o sistemi isolati non hanno bisogno di interagire con l’ambiente per
restare funzionanti mentre gli organismi sì (metabolismo);
La caratteristica principale degli organismi è
l’autorganizzazione ( l’ordine, la struttura e la funzione di un organismo non
sono imposti dall’ambiente ma sono stabiliti dal sistema stesso) e si articola
in auto rinnovamento (capacità dei sistemi viventi di riciclare e rinnovare di
continuo i proprio componenti conservano l’integrità della struttura
complessiva) e auto trascendenza (capacità di superare creativamente confini
fisici e mentali nei processi di apprendimento, sviluppo ed evoluzione); altra
caratteristica dei sistemi autorganizzantesi è la stabilità che non deve essere
confusa con l’equilibrio (che è statico): essa consiste nel mantenere la stessa
struttura nonostante i continui mutamenti e sostituzioni dei suoi componenti, e
può essere detta omeostasi.
La maggior parte degli organismi si integrano armonicamente
nel loro ambiente e alcuni di essi lo riplasmano. (ad esempio i polipi dei
coralli sono minuscoli organismi multicellulari che si uniscono fra loro per
formare grandi colonie e massicci scheletri calcarei e sono un ecosistema
perché ospitano innumerevoli batteri, piante e animali: questo fenomeno è noto
come simbiosi).
I rapporti fra i vari livelli di sistemi possono essere
rappresentati in un albero sistemico: come in un albero reale c’è
interconnessione tra tutti i livelli e ciascuno comunica con il suo ambiente
totale.
Il pianeta non solo pullula di vita ma sembra essere un
organismo vivente : tutta la materia vivente forma un sistema complesso che ha
tutte le forme caratteristiche dell’autorganizzazione; la terra è un sistema
vivo, non solo funziona come un organismo ma pare sia realmente un organismo:
Gaia, un essere vivente planetario.
La caratteristica fondamentale dell’evoluzione non è
l’adattamento ma la creatività:se fosse stata l’adattamento, sarebbe difficile
spiegare perché l’evoluzione è andata oltre il livello delle alghe azzurre, che
sono perfettamente adattate al loro ambiente. L’evoluzione è un processo aperto
senza un fine prestabilito. La teoria darwiniana pone l’accento solo sull’evoluzione
dell’organismo, mentre la teoria dei sistemi pone l’accento sulla coevoluzione
di organismo più ambiente.
Noi possiamo modificare il nostro comportamento cambiando i
nostri valori e atteggiamenti per riacquistare quella spiritualità e quella
consapevolezza ecologica che abbiamo perduto. Nella futura elaborazione della
nuova visione del mondo olistica, è probabile che la nozione di ritmo sia
destinata a svolgere un ruolo fondamentale. Tutta la realtà che ci circonda è
una danza ritmica continua.
|
Grazie per aver pubblicato il riassunto. Sto usando il testo come riferimento per un progetto di riorganizzazione territoriale, per praticare queste idee a livello sistemico -> https://sites.google.com/view/bassecomunitarie
RispondiEliminaVorrei segnalare che l'immagine dell'articolo alla copertina del libro è scomparsa...
Buone feste!