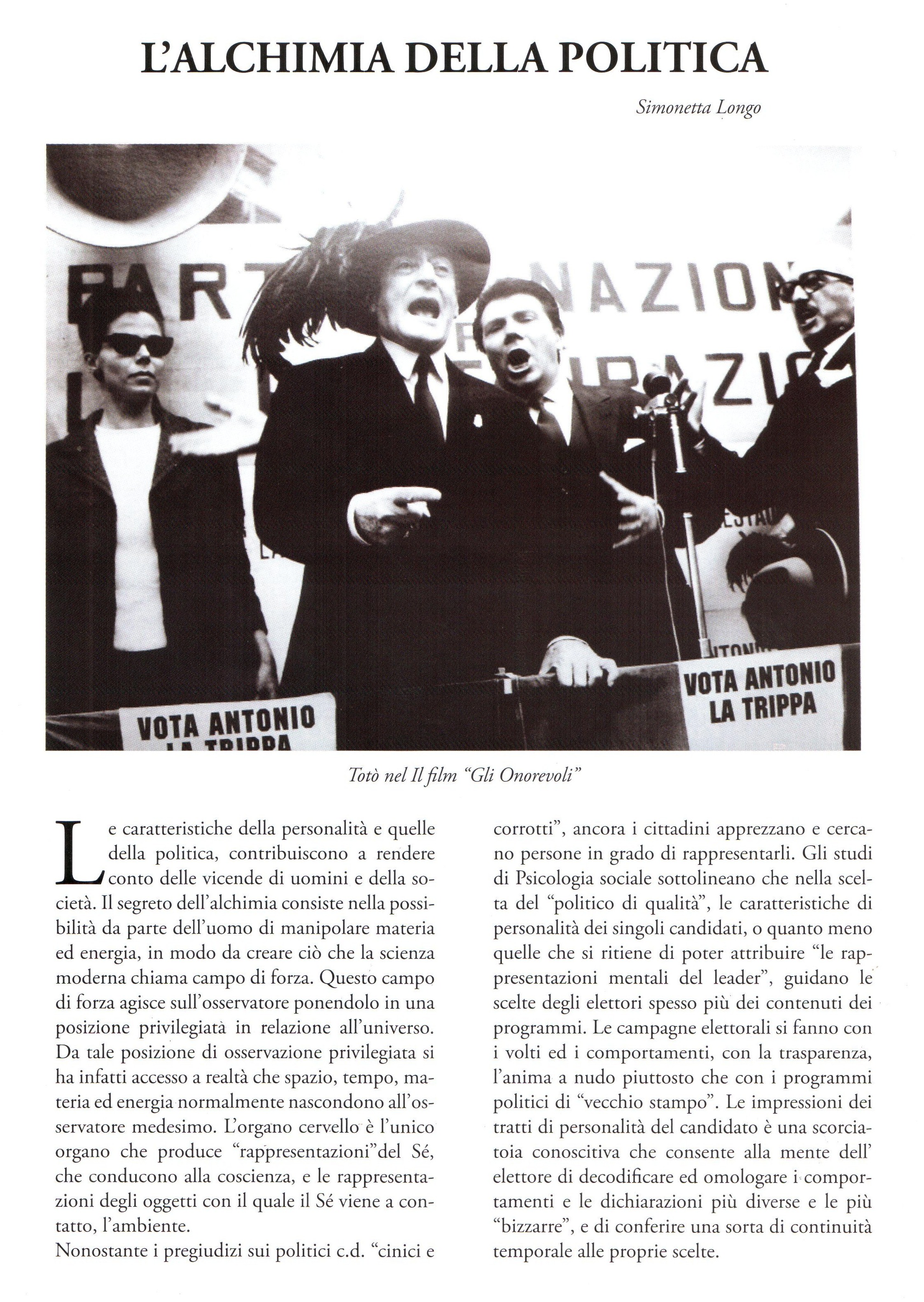martedì 21 gennaio 2014
domenica 19 gennaio 2014
Roberto De Mattei. Le origini della crisi europea......il Trattato di Maastricht
Roberto De Mattei. Le origini della crisi europea......il Trattato di Maastricht

Il Trattato di Maastricht, o Trattato sull'Unione Europea, è un trattato che è stato firmato il 7 febbraio 1992 a Maastricht, sulle rive della Mosa, dai dodici paesi membri dell'allora Comunità Europea, oggi Unione Europea, che fissa le regole politiche e i parametri economici necessari per l'ingresso dei vari Stati aderenti nella suddetta Unione. È entrato in vigore il 1º novembre 1993.
Conclusi i lavori della Conferenza intergovernativa, a Maastricht si apriva il 9 dicembre 1991 lo storico Consiglio europeo che avrebbe dato vita al nuovo Trattato.
Nella prima giornata furono sciolti gli ultimi nodi sull'Unione economica e monetaria: entro il 1º gennaio 1999 si sarebbe avviata la terza tappa del calendario, con l'introduzione della moneta unica. Più difficile fu superare l'opposizione britannica a questa soluzione e sulle questioni sociali. Venne sancita così la clausola di opting-out attraverso la quale la Gran Bretagna avrebbe potuto rimanere nella futura Unione europea pur senza accogliere le innovazioni che il suo governo avesse rifiutato. Nasceva così per la prima volta l'idea di un'Europa a due velocità.

Firmato il trattato di Maastricht
• Alle 18.05, alla Statenzaal, sede del governo provinciale del Limburgo (Olanda), mentre un’orchestrina suona un Divertimento
di Mozart, i rappresentanti dei dodici Paesi membri della Comunità
Europea (Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia,
Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna) firmano il
“trattato di Maastricht”, “passo storico” in direzione dell’unione
politica e monetaria, prevista al più tardi per il 1999.
I nove punti dell’accordo
•
Iltrattato di Maastrichtt, tradotto nelle nove lingue europee più il
gaelico (per far contenta l’Irlanda), è un compendio articolato delle
norme approvate separatamente al vertice dell’11 dicembre 1991.
In 320 pagine è introdotta una serie di importanti innovazioni rispetto
al precedente Trattato di Roma, la “Costituzione” della Cee entrata in
vigore nel 1958:
1) Unione economica-monetaria.
La moneta unica, traguardo finale dell’Unione, sarà creata entro il
1999 fra i Paesi che rispettino criteri relativi all’inflazione, ai
tassi d’interesse e alla finanza pubblica. Gran Bretagna e Danimarca
potranno autoescludersi;
2) Politica estera e di sicurezza comune.
I Dodici decideranno all’unanimità, in Consiglio europeo, quali sono i
settori di interesse comune. Le maggiori azioni in questo campo saranno
decise all’unanimità dai ministri degli Esteri, ma verranno poi condotte
con decisioni a maggioranza qualificata (finora ciascuno dei Dodici
aveva diritto di veto);
3) Politica di difesa. Includerà
tutte le questioni connesse con la sicurezza dell’unione europea,
compresa la formulazione finale di una politica comune di difesa;
4) Poteri dell’Europarlamento.
L’assemblea avrà un ampio spazio di codecisione e di “veto” in casi
estremi con il Consiglio dei ministri, avrà poteri d’inchiesta, peso
nella formazione della commissione europea e voce nella ratifica dei
maggiori trattati internazionali;
5) Coesione economica e sociale.
In favore di Grecia, Irlanda, Portogallo, Spagna, il trattato prevede
un fondo finanziato dagli altri Paesi per realizzare programmi nel
settore dell’ambiente e dei trasporti;
6) Politica sociale. Diventa una competenza della Comunità, anche se la Gran Bretagna rifiuta di associarsi;
7) Nuove competenze comunitarie.
Sanità, grandi reti di trasporti e comunicazioni, ambiente, ricerca,
cultura e industria (con decisioni unanimi), politica sociale,
protezione dei consumatori e cooperazione allo sviluppo. Energia,
turismo e protezione sono obiettivi per il ’96;
8) Cittadinanza.
Diritti riconosciuti ai cittadini dei Dodici fuori dall’Unione,
istituzione di un «ombudsman» (difensore civico), diritti di residenza e
di voto nelle elezioni locali;
9) Visti e permessi di soggiorno.
Il diritto di asilo e parte della politica di immigrazione verranno
resi soggetti a leggi comunitarie nel 1993, con lo sviluppo entro il
1994 di un’Europol, polizia di tipo federale.
L’Italia ratifica il Trattato di Maastricht
•
403 voti a favore, 46 contrari (Msi e Rifondazione), 18 astenuti (Verdi
e Rete più quattro deputati della Lista Pannella su cinque, il quinto,
estratto a sorte, ha votato sì), la Camera approva il Trattato di
Maastricht (il Senato aveva già detto si a settembre).

Il prof. Roberto de Mattei, allora presidente del Centro
Culturale Lepanto, e oggi della Fondazione Lepanto, esprimeva, tra i
primi in Europa, le sue critiche al Trattato di Maastricht in una
lettera consegnata a Strasburgo, a tutti i parlamentari europei, l’11
maggio del 1992, alla vigilia del discorso della regina Elisabetta di
Inghilterra al Parlamento Europeo. Lo stesso testo veniva fatto
pervenire, ai parlamentari italiani riuniti in seduta congiunta in
elezione del Presidente della Repubblica (il documento fu pubblicato
integralmente in « Lepanto », nn. 122-123 (maggio-giugno 1992), pp.
3-11).
La lettura di questa analisi, che precedette di quasi 10 anni
l’entrata in vigore dell’Euro, invita a riflettere sul nostro futuro.
Lettera ai Parlamentari europei del prof. Roberto de Mattei
Roma, 11 maggio 1992
Egregio onorevole,
a nome del Centro Culturale Lepanto, che ho l’onore di presiedere, vorrei sottoporre alla Sua attenzione alcune riflessioni a proposito di un importante dibattito che Ella e i suoi colleghi avete affrontato e dovrete ancora affrontare (l).
Mi riferisco al Trattato di Maastricht, stipulato l’11 dicembre 1991 nella cittadina olandese dai Capi di Stato e di Governo dei dodici Paesi della Comunità europea per avviare la nuova organizzazione internazionale denominata “Unione europea”.
Questo Trattato, che è stato formalmente sottoscritto il 7 febbraio 1992 e che, per entrare in vigore, dovrebbe essere ratificato dai rispettivi Parlamenti nazionali entro il 31 dicembre di quest’anno, sta suscitando un po’ ovunque crescenti dubbi e perplessità: unirà e rafforzerà veramente l’Europa, o la disgregherà, precipitandola nel caos? Lo scopo di questa lettera, è di contribuire ad una discussione su questo punto capitale.
Lettera ai Parlamentari europei del prof. Roberto de Mattei
Roma, 11 maggio 1992
Egregio onorevole,
a nome del Centro Culturale Lepanto, che ho l’onore di presiedere, vorrei sottoporre alla Sua attenzione alcune riflessioni a proposito di un importante dibattito che Ella e i suoi colleghi avete affrontato e dovrete ancora affrontare (l).
Mi riferisco al Trattato di Maastricht, stipulato l’11 dicembre 1991 nella cittadina olandese dai Capi di Stato e di Governo dei dodici Paesi della Comunità europea per avviare la nuova organizzazione internazionale denominata “Unione europea”.
Questo Trattato, che è stato formalmente sottoscritto il 7 febbraio 1992 e che, per entrare in vigore, dovrebbe essere ratificato dai rispettivi Parlamenti nazionali entro il 31 dicembre di quest’anno, sta suscitando un po’ ovunque crescenti dubbi e perplessità: unirà e rafforzerà veramente l’Europa, o la disgregherà, precipitandola nel caos? Lo scopo di questa lettera, è di contribuire ad una discussione su questo punto capitale.
lunedì 6 gennaio 2014
LA SCOMPARSA DI UN GRANDE ITALIANO. IL PROF. AUGUSTO GRAZIANI
LA SCOMPARSA DI UN GRANDE ITALIANO.
IL PROF. AUGUSTO GRAZIANI
"Anche l’Italia, che è uno degli ultimi paesi a realizzarlo, nel ’90 ammette la piena libertà dei movimenti di capitali. È evidente che si crea uno spazio finanziario europeo unico, un tasso d’interesse collegato in tutte le piazze finanziarie al quale ogni paese deve adeguarsi. Non è più possibile condurre una politica monetaria autonoma, non è più possibile mettere in prima linea l’obiettivo del sostegno della domanda globale e della piena occupazione, occorre recepire il tasso d’interesse dai vincoli esterni che vengono dai mercati finanziari maggiori. L’equilibrio finanziario prende il sopravvento come obiettivo primario rispetto al precedente obiettivo della piena occupazione". (Augusto Graziani, anno 1994)

Nasce a Napoli da una famiglia ebraica originaria di Modena, figlio del giurista Alessandro Graziani e nipote dell'economista Augusto Graziani (1865-1944), entrambi docenti a Napoli.
Consegue la laurea in economia e commercio presso l'università "Federico II" di Napoli proseguendo successivamente i suoi studi prima alla London School of Economics e poi all'Università Harvard in Massachusetts, USA.[1]
Nel 1962 diviene professore di economia politica presso l'università di Catania. Nel 1965 è professore di politica economica presso l'università di Napoli. Dal 1989 è professore ordinario di economia politica presso la facoltà di economia e commercio dell'Università "la Sapienza" di Roma.[2]
Durante la XI legislatura (1992-1994) è senatore della Repubblica nel gruppo del Partito Democratico della Sinistra.[3]
Fu membro dell’Accademia Nazionale dei Lincei, della Società nazionale degli economisti, dell’Accademia delle scienze di Torino, del consiglio direttivo della Fondazione Antonio Gramsci e dell’advisory board dello European Journal of the History of Economics Thought.[4]
Muore a Napoli il 5 gennaio 2014, dopo una lunga malattia
Augusto Graziani è noto per avere elaborato la Teoria del circuito monetario,[6] di cui è considerato uno dei fondatori e il principale esponente italiano.[
Fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/Augusto_Graziani
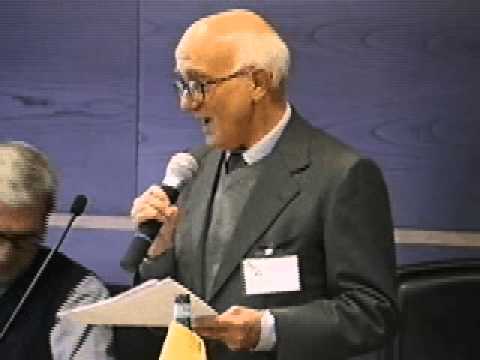
L’Italia prima e dopo l’euro.
luglio-agosto 2002
LA MONETA AL GOVERNO
Augusto Graziani
Allorché si prospettava l’adozione dell’euro come moneta unica, gli esperti concordavano nel prevedere per la nuova valuta il destino di una valuta forte. Nel loro insieme, i paesi ammessi a far parte dell’Unione monetaria (undici, in seguito divenuti dodici) formavano un mercato finanziario maggiore di quello statunitense; per di più, alcune delle valute che venivano fuse nell’euro potevano vantare una tradizione consolidata di stabilità e solidità, mentre la struttura industriale che stava alle spalle della nuova moneta era fra le più avanzate del mondo. Tutte queste previsioni erano destinate a risultare fallaci. A partire dal 1° gennaio 1999 e fino ad oggi (giugno 2002) la moneta europea, nonostante la recente ripresa, si è svalutata di circa il 20 % rispetto al dollaro e di oltre il 10% rispetto allo yen giapponese (lo stesso yen si è svalutato del 10% sul dollaro).
Per l’Italia, l’adozione di una moneta comune, unita all’andamento declinante del corso dell’euro rispetto alle altre grandi valute mondiali, ha significato l’abbandono di quello che era stato in passato un carattere tipico della politica valutaria italiana. In anni precedenti, quando l’Italia poteva condurre una politica valutaria indipendente, le autorità monetarie (Banca d’Italia e Tesoro) avevano sempre tentato di realizzare una sorta di linea differenziata. Da un lato veniva perseguito, se non un lieve apprezzamento della lira, almeno un tasso di cambio stabile rispetto al dollaro; questa linea aveva lo scopo di evitare l’aumento dei prezzi in lire delle importazioni quotate in dollari (anzitutto il petrolio, ma anche macchinari ad alta tecnologia, brevetti, apparecchi elettronici). Dall’altro, veniva vista con favore una lieve svalutazione della lira rispetto al marco tedesco, in quanto poteva incoraggiare le esportazioni verso i mercati europei. La strategia dei cambi differenziati era stata ufficialmente inaugurata fra il 1975 e il 1979 (il sistema di Bretton Woods era crollato fin dal 1971 con la dichiarazione di inconvertibilità del dollaro e l’Italia si muoveva in regime di cambi flessibili).
La Banca d’Italia era allora retta da Paolo Baffi, sostenitore convinto di questa strategia, ed altrettanto diffidente sulle possibilità che la lira italiana riuscisse a rispettare i vincoli che, a partire dal 1979, le sarebbero stati imposti con l’adesione, avvenuta nel febbraio del 1979, al Sistema monetario europeo. Questi lasciò che nel giro di un paio di anni la lira perdesse oltre il 10% del suo valore rispetto al marco. Una strategia non dissimile venne nuovamente adottata fra il 1992 e il 1996, quando la lira uscì dal Sistema monetario europeo e per quattro anni tornò ad essere una valuta liberamente fluttuante.
IL PROF. AUGUSTO GRAZIANI
"Anche l’Italia, che è uno degli ultimi paesi a realizzarlo, nel ’90 ammette la piena libertà dei movimenti di capitali. È evidente che si crea uno spazio finanziario europeo unico, un tasso d’interesse collegato in tutte le piazze finanziarie al quale ogni paese deve adeguarsi. Non è più possibile condurre una politica monetaria autonoma, non è più possibile mettere in prima linea l’obiettivo del sostegno della domanda globale e della piena occupazione, occorre recepire il tasso d’interesse dai vincoli esterni che vengono dai mercati finanziari maggiori. L’equilibrio finanziario prende il sopravvento come obiettivo primario rispetto al precedente obiettivo della piena occupazione". (Augusto Graziani, anno 1994)

Nasce a Napoli da una famiglia ebraica originaria di Modena, figlio del giurista Alessandro Graziani e nipote dell'economista Augusto Graziani (1865-1944), entrambi docenti a Napoli.
Consegue la laurea in economia e commercio presso l'università "Federico II" di Napoli proseguendo successivamente i suoi studi prima alla London School of Economics e poi all'Università Harvard in Massachusetts, USA.[1]
Nel 1962 diviene professore di economia politica presso l'università di Catania. Nel 1965 è professore di politica economica presso l'università di Napoli. Dal 1989 è professore ordinario di economia politica presso la facoltà di economia e commercio dell'Università "la Sapienza" di Roma.[2]
Durante la XI legislatura (1992-1994) è senatore della Repubblica nel gruppo del Partito Democratico della Sinistra.[3]
Fu membro dell’Accademia Nazionale dei Lincei, della Società nazionale degli economisti, dell’Accademia delle scienze di Torino, del consiglio direttivo della Fondazione Antonio Gramsci e dell’advisory board dello European Journal of the History of Economics Thought.[4]
Muore a Napoli il 5 gennaio 2014, dopo una lunga malattia
Augusto Graziani è noto per avere elaborato la Teoria del circuito monetario,[6] di cui è considerato uno dei fondatori e il principale esponente italiano.[
Fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/Augusto_Graziani
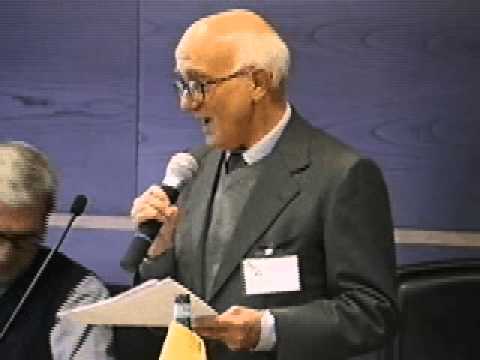
L’Italia prima e dopo l’euro.
luglio-agosto 2002
LA MONETA AL GOVERNO
Augusto Graziani
Allorché si prospettava l’adozione dell’euro come moneta unica, gli esperti concordavano nel prevedere per la nuova valuta il destino di una valuta forte. Nel loro insieme, i paesi ammessi a far parte dell’Unione monetaria (undici, in seguito divenuti dodici) formavano un mercato finanziario maggiore di quello statunitense; per di più, alcune delle valute che venivano fuse nell’euro potevano vantare una tradizione consolidata di stabilità e solidità, mentre la struttura industriale che stava alle spalle della nuova moneta era fra le più avanzate del mondo. Tutte queste previsioni erano destinate a risultare fallaci. A partire dal 1° gennaio 1999 e fino ad oggi (giugno 2002) la moneta europea, nonostante la recente ripresa, si è svalutata di circa il 20 % rispetto al dollaro e di oltre il 10% rispetto allo yen giapponese (lo stesso yen si è svalutato del 10% sul dollaro).
Per l’Italia, l’adozione di una moneta comune, unita all’andamento declinante del corso dell’euro rispetto alle altre grandi valute mondiali, ha significato l’abbandono di quello che era stato in passato un carattere tipico della politica valutaria italiana. In anni precedenti, quando l’Italia poteva condurre una politica valutaria indipendente, le autorità monetarie (Banca d’Italia e Tesoro) avevano sempre tentato di realizzare una sorta di linea differenziata. Da un lato veniva perseguito, se non un lieve apprezzamento della lira, almeno un tasso di cambio stabile rispetto al dollaro; questa linea aveva lo scopo di evitare l’aumento dei prezzi in lire delle importazioni quotate in dollari (anzitutto il petrolio, ma anche macchinari ad alta tecnologia, brevetti, apparecchi elettronici). Dall’altro, veniva vista con favore una lieve svalutazione della lira rispetto al marco tedesco, in quanto poteva incoraggiare le esportazioni verso i mercati europei. La strategia dei cambi differenziati era stata ufficialmente inaugurata fra il 1975 e il 1979 (il sistema di Bretton Woods era crollato fin dal 1971 con la dichiarazione di inconvertibilità del dollaro e l’Italia si muoveva in regime di cambi flessibili).
La Banca d’Italia era allora retta da Paolo Baffi, sostenitore convinto di questa strategia, ed altrettanto diffidente sulle possibilità che la lira italiana riuscisse a rispettare i vincoli che, a partire dal 1979, le sarebbero stati imposti con l’adesione, avvenuta nel febbraio del 1979, al Sistema monetario europeo. Questi lasciò che nel giro di un paio di anni la lira perdesse oltre il 10% del suo valore rispetto al marco. Una strategia non dissimile venne nuovamente adottata fra il 1992 e il 1996, quando la lira uscì dal Sistema monetario europeo e per quattro anni tornò ad essere una valuta liberamente fluttuante.
Iscriviti a:
Commenti (Atom)